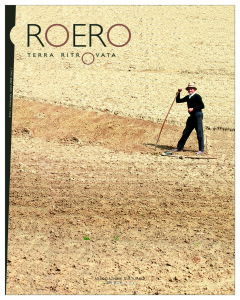Pubblichiamo parte del “racconto” di Carlo Petrini in apertura del volume fotografico Roero, di Carlo Avataneo
C’è tutta l’epica del Roero nelle immagini del libro di Carlo Avataneo. Epica, non semplicemente storia. La storia è lasciata a quelle porzioni di mondo in cui ai giorni succedono i giorni, alle notti fan seguito altre notti e così via senza che mai un sussulto vero, un respiro emozionale, una manifestazione di puro spirito vengano a turbare il corso delle opere e delle vicende. L’epica appartiene per contro alla dimensione dell’anima, è romanzo, variabilità e umore di una terra che vive della sua gente e nella sua gente, che sedimenta potenti sortilegi per tenere sempre in scacco l’ingenuo osservatore che le si accosti con occhio superficiale, pronta a spiazzare, a voltare pagina là dove svolta una strada o un sentiero, come altro risvolto della malìa e del sogno. (…)
Le fotografie di Carlo Avataneo hanno un pregio – un pregio che va al di là dell’inequivocabile livello tecnico delle stesse – che si può riassumere così: rendono in linguaggio dei sensi quel che la lingua non saprebbe esprimere. E ci sono due modi per sfogliare questo volume: il primo consiste nel passare a volo radente tutte le sue pagine senza soffermarsi su alcuna, solo facendosi catturare da un crescendo di visioni e moti interiori; il secondo, che io consiglio caldamente, indugia su ogni scatto, su ogni particella di luce e di ombra, su ogni profilo, e tende a dare inizio a un lungo sinuoso abbraccio con questa terra, fatto di ricordi, volti, attimi vissuti in simbiosi con essa.
Comincio da Bra il mio percorso tra le pieghe di una zona che ho amato e amo per averla vissuta e percepita a fondo. La mia città nel libro appare in filigrana, potente e sommessa, come intrappolata dentro gli sterili isterismi della vexata quaestio: ma Bra, in fondo, è veramente Roero? Ai posteri, se saranno più abili dei presenti, l’ardua sentenza. A noi che apparteniamo all’oggi vien da dire che Bra è tanto Roero quanto Langa, ovvero né l’uno né l’altra, dunque è entrambe le cose. Pazzie di una posizione geografica troppo equilibrata o, per dirla con i forestieri, politically correct! Eppure alle spalle della città, proprio pochi passi sopra quel Museo Craveri vanto della cittadina e di queste pagine che lo ritraggono come ritrarre una memoria, cominciano le ondulazioni che in men che non si dica mi hanno portato, in anni ormai passati, al ristorante l’Arcangelo. Il ricordo di Maria Pagliasso e di Carlo Arpino, braccio e mente (ma vale anche viceversa: mente e braccio) di quello che fu uno dei primi atti concreti del nostro agire da Arci Gola, è ancora così vivo che mi sembra di tornarci non solo con la mente ma anche col corpo, là su quella collina da cui – davvero – cominciava e comincia il Roero. Ma c’è un altro punto da cui, da Bra, si vede cominciare il Roero. Carlo Avataneo ne fa un ritratto doveroso ma non scontato: è Pollenzo. Siamo dalla parte opposta della città, giù nel basso, in quella conca di fondovalle che il fiume Tanaro ha scavato lasciandosi da una parte, a destra, le argille coriacee delle Langhe e dall’altra, a sinistra, le sabbie seducenti del Roero. Pollenzo, a dirla tutta, sta a sinistra del fiume: e per quanto sia intricato in quel punto tener dietro a tutte le anse del fiume-torrente, si può stare certi che questa è la verità. Se poi andiamo a misurare la portata culturale e d’immagine della rinnovata Agenzia – sede, tra l’altro, dell’Università di Scienze Gastronomiche e della Banca del Vino – ci accorgiamo con tutta evidenza che Pollenzo è un’istituzione capace oggi di parlare con il mondo, attirandone le attenzioni e i riflettori, pur rimanendo profondamente radicata su quella terra che l’ha espressa, sia essa Roero, Langa o in generale quel mondo a parte che sono le colline del nostro Piemonte. (…)




Lasciamo Bra, prendiamo le curve che seguono le carezze dei colli e perdiamoci nel mondo fatto di creste, forre e dirupi che sono le Rocche. Ho imparato nel tempo a ritmarle con i passi giusti: perdendo il conto di quante volte le ho scavalcate – all’altezza di Sommariva Perno, di Montaldo Roero, di Monteu Roero, di Montà – ho mantenuto invece viva la memoria dell’emozione che ogni volta ancora mi dà il solo loro vederle. Guardiamole allora, queste Rocche: c’è nel libro l’immagine di una radice sospesa nel vuoto del potente dirupo, che si lega al bordo del salto con sforzo indicibile, reclamando un sostegno per non cadere e, nel contempo, prendendosi tutta l’ebbrezza di quella posizione a volo libero sul mondo. Eccola di nuovo, l’epica del Roero, quel Roero purissimo, ancestrale e fecondo che a scavalco delle Rocche ha costruito la propria originaria identità. Ho incontrato, lassù in cima al mondo, contadini fieri dei loro frutteti cui mancava solo l’estetica dei terrazzamenti per farli sembrare testimoni di ben altri ambienti, ho visto i loro poderi e i loro beni aggrappati alla sabbia di un balzo, campi pensili tenuti su col pensiero e non solo con la zappa, e li ho visti tenere duro – i piedi ben piantati su un terreno che scappava via – anche quando, poco più in là sulle colline rese dolci dalla mano di altro dio, è giunta la fama meritata dei vini.
È un altro Roero, quello del vino. C’è un tratto che rende le colline del vino roerino qualcosa di più di un bel posto. E questo qualcosa non sta nei profili più o meno tondeggianti, negli anfiteatri più o meno ampi o nelle posizioni più o meno al sorì di queste alture. Sta nella gente che le abita, queste colline vitate di Roero. Io ho avuto la fortuna di conoscerla, questa brava gente. Sì, perché a volte nel conoscere la gente ci va anche un po’ di fortuna, soprattutto se poi capita qualcuno che prima c’era e adesso non c’è più, e tu resti a guardarti intorno per capire se mai tornerà, uno come lui. Uno come Matteo Correggia.
Matteo venne per la prima volta nei nostri nascenti uffici in un giorno di sole della primavera ’89. Aveva preso a far bottiglie in quella che allora era ancora – per molti – la Langa “di là da Tanaro”. Enologicamente parlando, s’intende. Cercava un’etichetta per i suoi vini e noi, guarda caso, avevamo nei nostri cassetti le immagini di colline stilizzate che aveva disegnato un singolare pittore sudamericano, Coco Cano. Diventarono l’emblema della cantina Matteo Correggia, fissandosi sul vetro di quei vini di cui corse presto la fama molto al di là del fiume… Ora, non è perché lui non c’è più – se n’è andato nel 2001, alla maniera tragica dei piccoli eroi, portando con sé l’interruttore di una gioia che da allora non sappiamo più accendere – che ne parlo qui. Matteo ha davvero inventato il Roero del vino così come altri lo hanno poi perpetuato, affinato, attualizzato e rilanciato. (…)
Voglio godermi un po’ i boschi del Roero. Avataneo li tratta quasi alla stregua di un avamposto remoto di foresta primordiale: e certe immagini di verde e di nebbioline soffuse danno l’idea, ancora una volta, di essere in un altro mondo. Invece l’altro mondo è il Roero. I “castagnoni della Madonna” – sembra quasi un ulteriore accrescitivo, in realtà è un toponimo di Montaldo Roero! –, i boschi di querce e noci, di faggi e di olmi sono un inno a quel che dovremmo sempre portare con noi: un albero è per sempre, si potrebbe giocare con le parole, e in realtà più che da giocarci c’è da stare ben attenti che i sentieri siano sempre puliti, che il taglio sia funzionale all’utilizzo domestico, e che il sottobosco consenta ancora di trovare, quand’è stagione, quei preziosi tuberi in guisa di funghi, se han voglia di emergere, o di tartufi, che allora tocca tirar fuori la pila e camminar di notte per non esser visti. (…)




C’è un Roero da celebrare in queste pagine, e se penso a una celebrazione penso a una festa, e se ho in mente una festa ho in mente una tradizione di collina, allora vuol dire che penso a cantè j’euv. (…) Specchio di una società meno complessa economicamente ma molto evoluta sotto il piano sociale e antropologico, il cantè j’euv nel Roero ha resistito molto più che altrove al diluvio che nei decenni seguiti al conflitto mondiale ha fatto tabula rasa degli usi e dei saperi delle comunità rurali, in Italia come nel resto d’Europa. Non solo ha resistito: da cantè j’euv è partita una sorta di nuova scommessa sui saperi orali e tradizionali che ha indotto a rispolverare altri aspetti della vita comunitaria di queste terre. Le immagini di Avataneo ci riferiscono del Maggio, dell’infiorata del Corpus Domini, delle tombe decorate con sabbia e fiori del giorno dei morti, dei coscritti, ma mi sono giunte notizie anche di una nuova stagione delle veglie invernali, delle feste del grano e della vendemmia, mentre plaudo sempre alle iniziative promosse da Luciano Bertello per il recupero dei falò nella notte di San Giovanni. (…)
Il Roero è terra nobile, terra antica e terra di re. L’aristocrazia della sinistra Tanaro trova molto spazio nel libro. È giusto. Il profilo del Roero disegna, prima ancora che l’arco perfetto di una collina, il tratto nervoso e altrettanto perfetto di un castello o di una torre. Tra edifici tuttora in piedi – la maggior parte, tra l’altro, in ottime condizioni –, resti più o meno rabberciati e tracce lasciate su siti poi ricostruiti, non si contano quasi i manieri in terra di Roero. Alcuni di essi ospitano oggi importanti istituzioni museali, artistiche o culturali; altri, di natura per lo più privata, si aprono di tanto in tanto a manifestazioni e vetrine prestigiose; altri ancora sono in fase di delicato passaggio generazionale tra i proprietari e potrebbero presto diventare importante risorsa conoscitiva per il territorio. Occorre creare una rete tra queste strutture e offrire ai visitatori l’opportunità di itinerari dal fascino indiscutibile. Tra Guarene e Govone, Castellinaldo e Canale, Monteu Roero e Monticello – solo per citare alcuni esempi tra i più belli e significativi – ci sono le premesse per un circuito storico-artistico che non teme rivali in Italia e che può tranquillamente competere con esempi ben più noti all’estero. Negli anni scorsi, alla ricerca dei sapori autentici del Roero, ho più volte sostato all’ombra di questi residui di antiche glorie e, come nei Sepolci di Foscolo sono le tombe degli antichi a raccontare le gesta e le avventure dei loro protagonisti, in questo caso bastioni e fossati, merli e torrioni mi hanno raccontato la storia di un piccolo mondo lontano, fondale perfetto su un palcoscenico vivo dei fremiti della sua radice profonda, aggrappato alla memoria come quelle piante all’orlo delle Rocche, cuore pulsante di una storia che cambia volti e cambia padroni, ma resta sempre quella, avvincente e duratura come un bel pensiero.
Il Roero di Avataneo, alla fine, è il mio Roero. Perché non ne tratteggia un solo aspetto, magari analizzandolo a fondo fino a non lasciare ad altri la soddisfazione di un possibile seguito: ne fa la cronistoria appassionata di tutte le sue molteplici e volubili facce, senza la pretesa esaustiva di raccontare tutto di tutto, ma con la bravura di cogliere l’essenziale nel generale, e la sfumatura nel dettaglio. E ti ritrovi a viaggiare, come ho fatto io per lunghissimo tempo e come faccio volentieri tuttora: su e giù per le colline che raccontan di noi perché sulle colline ci siamo nati un po’ tutti; dentro e fuori le cantine che hanno visto reinventarsi un territorio; ai tavoli delle osterie che – non ne abbiamo parlato, ma meritano di essere scoperte – hanno lasciato invitto quel filo sottile che ci lega al senso vero del nostro vivere; alla natura che ci apre le porte dello spirito, e ci introduce alla gente, e ce la fa scolpire per sempre dentro di noi. Il Roero è Roero. Punto. Pronunciarlo sa già di arcano e sa di avventura. Sono andato a rileggermi qualche dato statistico, che adesso, alla fine del viaggio, può essere tranquillamente snoccioalto senza timore di essere scambiati per analisti: 357 kmq per 50 000 abitanti. Un fazzoletto di terra, in cui tutto è a dieci minuti d’auto, abitato da un pugno (per quanto grosso) di roerini. Il futuro si gioca anche su una capacità di gestire l’equilibrio tra territorio e sviluppo, voglia di crescere e contenimento: nel Roero da sempre si cerca un difficile compromesso tra questi aspetti dicotomici eppure, necessiamente, complementari. Ho conosciuto generazioni di amministratori del Roero e sempre ho visto balenare nei loro occhi la tensione accesa del futuro. Che fare di un Roero? Che fare di tutti i Roero che ci sono al mondo? Perché di Roero ce n’è uno, questo sì, ma di territori belli e fragili ve ne sono tanti e tutti reclamano una risposta per il futuro che sia prima di tutto speranza.
Qui non è sentimento mal riposto, la speranza. Se dopo tutti i chilometri fatti sotto il cielo di Roero, se dopo le cantate e le lune, se dopo le bevute e i brividi fin qui lasciati correre sotto pelle, siamo ancora a parlare del Roero in questi termini, vuol dire che l’humus che ha spinto il territorio fino ai giorni nostri è ben fertile. Che sia fatto di tanti giovani, è un augurio. Che sia fatto di gente generosa e fortunata, è il mio auspicio. Che sia sempre come oggi – una riuscita sospensione tra quel era e quel che sarà – è un desiderio che mi porto via con queste ultime righe, lasciandolo a ciascuno dei piccoli grandi roerini che hanno contribuito alla sua affermazione oltre il muro dei sogni impossibili.